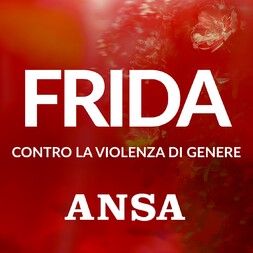A teatro ci sono i mattatori, al
cinema i divi, in tv i fine dicitori e gli showmen. E in tutti e
tre questi palcoscenici ci sono i grandi attori dal passo
felpato, quelli che entrano in scena quasi senza farsi accorgere
e poi calamitano gli sguardi e non li lasciano più. Aldo Giuffré
(Napoli, 10 aprile 1924 - Roma, 26 giugno 2010) apparteneva a
questa categoria e oggi lo si deve ricordare non solo come un
grande professionista ma come un gentiluomo elegante, un
napoletano colto e raffinato, un cittadino del mondo grazie alla
sua cultura e ai suoi grandi maestri, da Eduardo a Totò, da
Visconti a Baseggio, fino a Strehler.
Suo padre suonava all'orchestra del Teatro San Carlo e oltre
a lui mise al mondo due bimbe e il fratello più giovane, Carlo,
in pochi anni. Poi se ne andò ad appena 47 anni, stroncato da
una polmonite, lasciando la moglie Maria da sola a crescere la
famiglia. A Napoli c'era la guerra e il giovane Aldo fece subito
amicizia coi liberatori americani; in città c'era una sede
dell'Eiar, la radio nazionale, e da lì Giuffré cominciò la sua
carriera come annunciatore. Passato a Roma, in via Asiago, fu
lui ad annunciare nel 1945 la fine dei combattimenti. Dopo una
particina a fianco di Anna Magnani in "Assunta Spina" (il suo
debutto al cinema nel 1947), la chiamata di Eduardo De Filippo
in compagnia per "Napoli milionaria". Con De Filippo rimase tre
anni, trovando però il tempo per qualche incursione al cinema
come ne "L'imperatore di Capri" di Luigi Comencini.
Nel '50 ebbe il battesimo del fuoco a Cinecittà con 5
pellicole nel solo 1950, ritrovando anche il "suo" Eduardo negli
adattamenti per lo schermo di "Napoli milionaria" e "Filumena
Marturano". Per raccontare Aldo Giuffré si deve però partire
sempre e comunque dal teatro perché qui ebbe le maggiori
soddisfazioni con un repertorio ricco di sfide importanti con
Cechov, Goldoni, Pirandello grazie a registi come Luchino
Visconti, Orazio Costa, Guido Salvini che lo guidò in una
memorabile versione di "Questa sera si recita a soggetto" nel
1957. Nello stesso anno si cimentò per la prima volta da autore
con la commedia brillante di Scarnicci e Tarabusi ("Caviale e
lenticchie") per poi debuttare da regista con "Mettiamo le carte
in tavola" scritto insieme ad Antonio Ghirelli. La
collaborazione con Giorgio Strehler risale al 1964 con il
successo travolgente di "Le notti dell'ira" da Salacru, ma nei
decenni successivi sempre più spesso si affiderà a se stesso,
magari alternandosi con il fratello Carlo che divide con lui
palcoscenico e compagnia fin da "Un coperto in più" del 1972, da
un testo di Maurizio Costanzo.
Intanto la televisione lo ha reso un volto popolare già dagli
anni '60. Proprio nel 1961 tocca a lui l'onore di inaugurare il
secondo canale della Rai con "La trincea" di Dessì per la regia
di Vittorio Cottafavi per poi dividersi con successo tra
sceneggiati, prosa, varietà diventando un collaudato showman.
Qualche titolo di una fortunata stagione durata due decenni: "La
figlia del capitano", "Le avventure di Laura Storm", "Un mese in
campagna", "L'eredità della priora", il varietà "Senza rete".
A questo bilancio complessivo il cinema contribuì certamente
in modo determinante benché poche volte gli fu lasciato lo
spazio del protagonista, pur in film di successo. A fianco di
Totò fu impareggiabile spalla da "Totò e Tarzan" a "Totò terzo
uomo", da "Guardie e ladri" a "Il medico dei pazzi". Fu nel cast
di "Carosello napoletano" (il primo titolo a colori del cinema
italiano nel 1954); poi Francesco Rosi lo chiamò per il suo
esordio nel 1959 ("I magliari") e Nanni Loy gli diede il giusto
rilievo ne "Le quattro giornate di Napoli" (1962). Vittorio De
Sica lo volle nell'episodio "Adelina" di "Ieri, oggi e domani"
(1963) mentre i registi del cinema più popolare (Sergio Corbucci
e Lucio Fulci, Pietro Francisci e Steno) se lo contendevano
sugli sfondi più diversi, tra il mitologico e la commedia.
Riproduzione riservata © Copyright ANSA